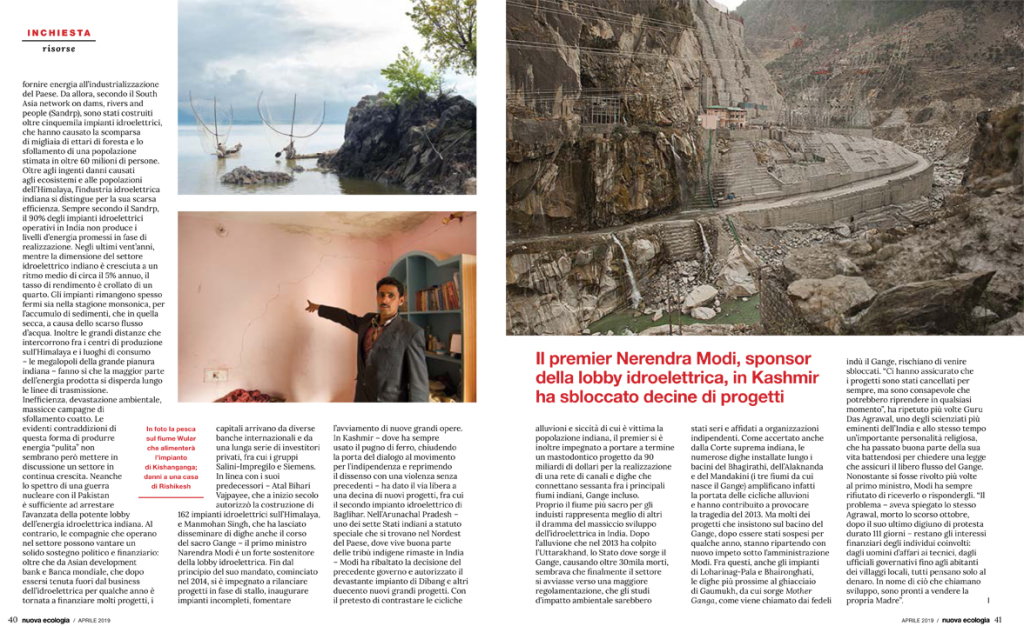Ogni volta che la tensione con il Pakistan s’infiamma, il governo indiano minaccia di chiudere il rubinetto al suo vicino. “L’India è pronta a interrompere il flusso delle sue acque verso il territorio pakistano: il corso dei nostri fiumi verrà deviato a favore delle popolazioni di Jammu, Kashmir e Punjab”, ha twittato Nitin Gadkari, ministro indiano delle risorse idriche e dei trasporti, a ridosso dell’attentato di febbraio a Pulwama, rivendicato dal gruppo separatista Jaish-e-Mohammed basato in territorio pakistano e in cui sono rimasti uccisi 44 paramilitari indiani impegnati in Kashmir. Una misura che se messa davvero in pratica equivarrebbe a una dichiarazione di guerra tra due Paesi che hanno a disposizione un arsenale atomico.
Sul territorio kashmiro controllato dall’India scorrono infatti tutti gli affluenti dell’Indo, il fiume da cui dipende oltre l’80% dell’agricoltura pakistana e la sopravvivenza di decine di milioni di persone. Uno straordinario dedalo di fiumi disseminato dal governo indiano di dighe e impianti idroelettrici, che oltre a una preziosa fonte di energia per l’economia indiana, rappresentano una minaccia costante per i fragili equilibri geopolitici regionali. La disputa per il territorio del Kashmir – già causa di 4 campagne militari dall’indipendenza dai colonizzatori inglesi (1947) – si è trasformata così in una contesa soprattutto per le risorse idriche.
A regolare i diritti sulle acque dell’Indo sono i dodici articoli dell’Indus Water Treaty, voluto dalla Banca mondiale e sottoscritto nel 1960 da India e Pakistan “in spirito di buona volontà e amicizia”: i tre affluenti orientali (Beas, Ravi e Sutlej) sono assegnati al controllo indiano, mentre i tre occidentali (Indo, Chenab e Jelhum) sono di pertinenza pakistana. Fin dai primi anni Novanta però il governo di New Delhi studia le more del Trattato per sfruttare anche le acque destinate al Pakistan, rassicurando la comunità internazionale con la garanzia che una volta passata attraverso le turbine degli impianti idroelettrici ogni goccia d’acqua viene restituita al corso dei fiumi.
In Pakistan la questione infiamma gli animi e alimenta la propaganda anti-indiana più radicale, mentre le vie ufficiali finora non hanno portato risultati favorevoli alla diplomazia pakistana. I ripetuti appelli alle istituzioni internazionali sulle presunte violazioni indiane degli accordi sottoscritti nell’Indus Water Treaty sono stati tutti rigettati: la Banca mondiale ha dato il nullaosta alla costruzione delle dighe indiane di Baglihar sul fiume Jhelum e di Ratle sul fiume Chenab, mentre la sentenza finale della International Court of Arbitration (Ica) dell’Aja ha riconosciuto all’India il diritto di portare a termine anche la diga di Kishanganga sull’omonimo affluente dello stesso Jhelum.
Ad aggravare la situazione contribuisce poi il riscaldamento climatico: secondo gli studi più recenti, gran parte dei ghiacciai himalayani rischia di sciogliersi entro la fine del secolo causando, dopo un’iniziale aumento di flusso, il progressivo prosciugamento di molti fiumi. La portata dell’Indo dovrebbe diminuire dell’8% entro la metà del secolo. Uno scenario che rischia di inasprire la tensione tra le due potenze nucleari.
Sono passati oltre cinquant’anni da quando nel 1963 Jawaharlal Nehru, compagno del Mahatma Ghandi e leader storico dell’India indipendente, inaugurò il primo colossale impianto idroelettrico indiano: la diga di Bhakhra sul fiume Satluj venne presentata alla popolazione come “un tempio dell’India moderna”. Nel disegno di Nehru le dighe avrebbero dovuto portare acqua corrente alle famiglie indiane, irrigare i campi coltivati, fornire energia all’industrializzazione del Paese. Da allora, secondo il South Asia Network on Dams, Rivers and People (Sandrp), sono stati costruiti oltre 5mila impianti idroelettrici, che hanno causato la scomparsa di migliaia di ettari di foresta e lo sfollamento di una popolazione stimata in oltre 60milioni di persone.
Oltre agli ingenti danni causati agli ecosistemi e alle popolazioni dell’Himalaya, l’industria idroelettrica indiana si distingue per la sua scarsa efficienza. Sempre secondo il Sandrp, il 90% degli impianti idroelettrici operativi in India non produce i livelli d’energia promessi in fase di realizzazione. Negli ultimi 20 anni, mentre la dimensione del settore idroelettrico indiano è cresciuta a un ritmo medio di circa il 5% all’anno, il tasso di rendimento è crollato di un quarto. Gli impianti rimangono spesso fermi sia nella stagione monsonica, per l’accumulo di sedimenti, sia in quella secca, a causa dello scarso flusso d’acqua. Inoltre le grandi distanze che intercorrono tra i centri di produzione sull’Himalaya e i luoghi di consumo – le megalopoli della grande pianura indiana – fanno si che la maggior parte dell’energia prodotta si disperda lungo le linee di trasmissione.
Inefficienza, devastazione ambientale, massicce campagne di sfollamento coatto. Le evidenti contraddizioni di questa forma di produrre energia “pulita” non sembrano però metter in discussione un settore in continua crescita. Neanche lo spettro di una guerra nucleare con il Pakistan è sufficiente ad arrestare l’avanzata della potente lobby dell’energia idroelettrica indiana. Al contrario, le compagnie che operano nel settore possono vantare un solido sostegno politico e finanziario: oltre ad Asian Development Bank e Banca mondiale, che dopo essersi tenuta fuori dal business dell’idroelettrica per qualche anno è tornata a finanziare molti progetti, i capitali arrivano da diverse banche internazionali e da una lunga serie d’investitori privati, tra cui i gruppi Salini-Impregilo e Siemens.
In linea con i suoi predecessori – Atal Bihari Vajpayee, che a inizio secolo autorizzò la costruzione di 162 impianti idroelettrici sull’Himalaya, e Manmohan Singh, che ha lasciato disseminare di dighe anche il corso del sacro Gange – il Primo ministro Narendra Modi è un forte sostenitore della lobby idroelettrica. Fin dal principio del suo mandato, cominciato nel 2014, si è impegnato a rilanciare progetti in fase di stallo, inaugurare impianti ancora incompleti, fomentare l’avviamento di nuove opere smisurate. In Kashmir – dove ha sempre usato il pugno di ferro, chiudendo la porta del dialogo al movimento popolare per l’indipendenza e reprimendo il dissenso con una violenza senza precedenti – ha dato il via libera a una decina di nuovi progetti, tra cui il secondo impianto idroelettrico di Baglihar. Nell’Arunachal Pradesh – una delle “Sette Sorelle”, gli Stati indiani a statuto speciale che si trovano nel Nordest del Paese, dove vive buona parte delle tribù indigene rimaste in India – ha ribaltato la decisione del precedente governo e autorizzato il devastante impianto di Dibang e altri 200 nuovi grandi progetti. Con il pretesto di contrastare le cicliche alluvioni e siccità di cui è vittima la popolazione indiana, Modi si è inoltre impegnato a portare a termine un mastodontico progetto da 90 miliardi di dollari per la realizzazione di una rete di canali e dighe che connettano 60 tra i principali fiumi indiani, incluso il Gange.
Proprio il fiume più sacro per gli induisti rappresenta meglio di altri il dramma del massiccio sviluppo dell’idroelettrica in India. Dopo l’alluvione che nel 2013 ha colpito l’Uttarakhand, lo Stato dove sorge il Gange, causando oltre 30mila morti, sembrava che finalmente il settore si avviasse verso una maggiore regolamentazione, che gli studi d’impatto ambientale sarebbero stati seri e affidati a organizzazioni indipendenti. Come accertato anche dalla Corte Suprema indiana, le numerose dighe installate lungo i bacini del Bhagirathi, dell’Alaknanda e del Mandakini (i tre fiumi da cui nasce il Gange) amplificano infatti la portata delle cicliche alluvioni e hanno contribuito a provocare la tragedia del 2013. Al contrario però molti dei progetti che insistono sul bacino del Gange, dopo essere stati sospesi per qualche anno, stanno ripartendo con nuovo impeto sotto l’amministrazione Modi.
Tra questi, anche gli impianti di Loharinag-Pala e Bhaironghati, le dighe più prossime al ghiacciaio di Gaumukh (alla lettera “la bocca della mucca”) da cui sorge Mother Ganga, come viene chiamato dai fedeli indù il Gange, rischiano di venire sbloccati. “Ci hanno assicurato che i progetti sono stati cancellati per sempre, ma sono consapevole che potrebbero riprendere in qualsiasi momento”, ha ripetuto più volte Guru Das Agrawal, tra gli scienziati più eminenti dell’India e importante personalità religiosa, che ha passato buona parte della sua vita battendosi per chiedere una legge che assicuri il libero flusso del sacro Gange. Nonostante si fosse rivolto più volte al Primo ministro, Modi ha sempre rifiutato di riceverlo o rispondergli. “Il problema – ha spiegato GD Agrawal, morto lo scorso ottobre, dopo un ultimo digiuno di protesta durato 111 giorni – restano gli interessi finanziari degli individui coinvolti: dagli uomini d’affari ai tecnici, dagli ufficiali governativi fino agli abitanti dei villaggi locali, tutti pensano solo al denaro. In nome di ciò che chiamano sviluppo, sono pronti a vendere la propria Madre”.